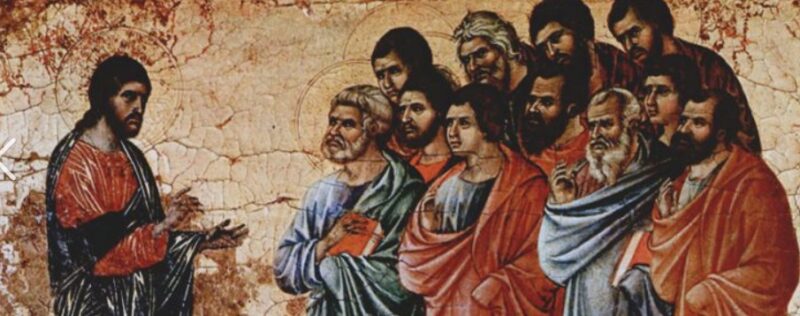Arcivescovo_Meditazione_Giornata_Santificazione_2025
Arcivescovo_Meditazione_Giornata_Santificazione_2025 
«Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “la messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!”». (Mt 9,35-38)
Questo piccolo brano di Matteo è il riferimento biblico che motiva e fonda la necessità della preghiera per le vocazioni.
Alla base dell’esortazione di Gesù, “pregate il padrone della messe…”, c’è la coscienza del contrasto tra l’abbondanza della messe da raccogliere, e il numero esiguo degli operai. Ma cosa significa propriamente che la messe è molta e gli operai sono pochi? E che cosa si intende quando si chiede al padrone di mandare operai nella sua messe? I pochi versetti che prendiamo in esame ci danno alcune risposte.
Contesto: il discorso missionario
Il testo fa parte del discorso missionario che, nel vangelo di Matteo, è preceduto dal discorso della montagna e seguito dal discorso parabolico, dal discorso ecclesiale e dal discorso escatologico.
La scena del discorso missionario è dominata dalla missione di Gesù esplicitamente menzionata in apertura (Mt 9,35) e alla conclusione (Mt 11,1). L’invio dei 12 dà inizio ad una missione aperta che si prolunga oltre la loro attività storica (Mt 9,38). Il discorso si rivolge direttamente ai 12, ma per mezzo di essi si estende a tutti coloro che ne prolungano l’opera.
“Gesù è il primo apostolo, il figlio inviato ai fratelli dalla compassione del Padre. La Chiesa è apostolica non solo perché ha negli apostoli – e, attraverso di loro, in Gesù primo apostolo, – la propria origine, ma anche perché è fatta di figli che si sentono inviati ai fratelli” (Silvano Fausti, Una comunità legge il vangelo di Matteo I, EDB, Bologna 1998, p. 175).
Ecco la struttura generale del discorso:
- cornice: missione di Gesù, 9,35-38
presentazione dei dodici, 10,1-5°
- istruzione agli inviati: programma/stile e accoglienza, 10,5b-15
- esortazioni/promesse ai discepoli perseguitati, 10,16-23
- principio della conformità maestro/discepolo, 10,24-25
C’. esortazioni/promesse ai discepoli perseguitati, 10,26-39
B’. istruzioni agli inviati: accoglienza, 10,40-42
A’. cornice: missione di Gesù, 11,1
La struttura si presenta a forma di inclusione con una disposizione che ruota attorno ai due versetti centrali 10,24-25 (“Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone; è sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone”): questo orientamento cristologico diventa l’asse portante dell’intero discorso.
Struttura di Mt 9,35-38
I versetti 35-38 sono, dunque, una introduzione al “discorso missionario” che raccoglie le istruzioni impartite da Gesù ai Dodici, prima di inviarli. È possibile individuare tre parti: descrizione dell’attività di Gesù (9,35); compassione da parte di Cristo pastore nei confronti delle folle (9,36); parole rivolte ai discepoli: considerazione circa la messe e gli operai e invito alla preghiera (9,37-38).
Prima parte. Attività di Gesù (9,35)
Il nostro brano è posto dopo una serie di miracoli. Gli ultimi ad essere narrati sono la guarigione dell’emorroissa che da dodici anni soffriva di perdita di sangue: “coraggio, figlia” (9,22); la risurrezione di una fanciulla che a dodici anni era morta: “prese la fanciulla per mano e lei si alzò” (9,25); la guarigione di due ciechi che si rivolgono a Gesù dicendo: “abbi misericordia di noi, figlio di Davide!” (9,27); un esorcismo che riabilita la persona guarita a riappropriarsi della parola (9,33a). Di fronte a tutto ciò le folle dicono: “mai è apparsa cosa simile in Israele” (9,33b). In Gesù si è manifestato il cuore appassionato di Dio per il suo popolo.
Gesù “andava attorno per tutte le città e i villaggi”. “Tutte” sta ad indicare una totalità, una apertura e disponibilità che esclude ogni restrizione di campo o limitazione di energie da spendere, ogni selezione dei destinatari. “Tutte” indica l’intensa attività missionaria di Gesù che insegna nelle sinagoghe, annuncia il vangelo del regno e cura le malattie. È a questa missione che i discepoli vengono chiamati a collaborare: cf 10,1.8; 10,7; 10,11. I discepoli sono totalmente relativi a Gesù e totalmente dediti alla sua missione, quella del Signore, non svolgono una missione a proprio nome.
Essere totalmente relativi a Gesù e alla sua missione ci impegna a riflettere anche su un altro aspetto: quando diciamo le nostre attività, le nostre parrocchie, il nostro sacerdozio… Sarebbe interessante verificarci su questo “nostre”, quanto stia a significare il dare una caratterizzazione personale ad attività, parrocchia, secondo i doni ricevuti, i tratti caratteristici che ci costituiscono, e quanto, invece, stia a significare una proprietà, un attaccamento inadeguato, un fondare tutto sui mezzi propri e non su Cristo.
Seconda parte. Compassione di Gesù (9,36)
“Vedendo le folle ne sentì compassione”. In Mt 5,1-2 è detto dell’iniziativa presa da Gesù alla vista delle folle: “Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo…”. Una iniziativa che lo porta ad insegnare; questa volta la vista delle folle lo commuove e lo porta a dire che la messe è molta, gli operai sono pochi e, poi, ad inviare i dodici. Gesù, commosso, si prende cura delle folle, sono proprio queste folle la messe di cui Gesù parla ai discepoli.
Spesso nei vangeli il verbo “vedere” riferito a Gesù si abbina al verbo “commuoversi”. Per esempio, il miracolo della moltiplicazione dei pani inizia tutto da uno sguardo di amore e di pietà da parte del Maestro: “Egli sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati” (Mt 14,13). Anche il miracolo del figlio della vedova di Nain parte dagli occhi del Signore: “In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: “Non piangere!”. E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: “Giovinetto, dico a te, alzati!”. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre” (Lc 7, 11-15).
Il vedere di Gesù possiede la capacità di “radiografare” la situazione esistenziale delle folle: le vede stanche e prostrate. Altri avrebbero visto un movimento di gente che seguiva un profeta, e niente più. Per Gesù, invece, è una scena che tocca il cuore e ferisce l’anima. È uno sguardo che sa andare oltre ciò che appare, sa cogliere il cuore dell’altro e allo stesso tempo sa coinvolgere il proprio cuore. È uno sguardo di empatia. Pensiamo alle relazioni che viviamo nel nostro servizio pastorale se sono conseguenza di uno sguardo superficiale, freddo, alla ricerca di una gratificazione personale, distante; oppure sono frutto di uno sguardo che sa realisticamente conoscere e riconoscere la realtà e coinvolgere di conseguenza il cuore?
Gesù non solo guarda oltre l’apparenza, vedendo ciò che l’uomo è, ma vede anche ciò che l’uomo non riesce ad essere ancora ma che è chiamato a diventare. È a partire da questo guardare oltre, dalla percezione della distanza tra ciò che l’uomo è e ciò che è chiamato a diventare e ancora non riesce ad essere che nasce la commozione.
Credo che anche a noi sacerdoti, come pastori, educatori, è richiesta questa capacità. Una capacità che domanda impegno, coinvolgimento profondo, rifiuto di accontentarci di una situazione di fatto (che pur domanda di essere conosciuta realisticamente, senza distorsioni, e ciò non è per niente facile) e capacità di conoscere l’ideale verso cui accompagnare la persona o la comunità (può a questo proposito essere interessante citare W. Goethe: “Se prendiamo l’uomo come è, lo rendiamo peggiore; se prendiamo l’uomo come dovrebbe essere, lo aiutiamo a diventarlo”).
Cosa vede Gesù: vede che “erano stanche e sfinite come pecore senza pastore”.
L’immagine delle pecore senza pastore ci richiama la polemica dei profeti contro i pastori inautentici che pascono se stessi, per cui le pecore si sono disperse, preda delle bestie selvatiche:
“[1] Mi fu rivolta questa parola del Signore: [2]”Figlio dell’uomo, profetizza contro i pastori d’Israele, predici e riferisci ai pastori: Dice il Signore Dio: Guai ai pastori d’Israele, che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? [3] Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. [4] Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. [5] Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate. [6] Vanno errando tutte le mie pecore in tutto il paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. [7] Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore: [8] Com’è vero ch’io vivo, – parla il Signore Dio – poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto d’ogni bestia selvatica per colpa del pastore e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge – hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge – [9] udite quindi, pastori, la parola del Signore: [10] Dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori: chiederò loro conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge, così i pastori non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto” (Ez 34,2-10).
I pastori sono venuti meno alla loro missione, non sono stati vere guide.
La polemica di Gesù contro scribi e farisei tocca proprio questo aspetto: da una parte loro che sono stati messi a capo del popolo per guidarlo, che hanno ricevuto una particolare vocazione, dall’altra la situazione drammatica del popolo senza vere guide che non ha pascolo, è smarrito, è attaccato da bestie feroci (cf. Mt 23,18).
Dunque, la motivazione profonda dell’impegno messianico-salvifico di Gesù, che deve prolungarsi nel compito dei discepoli, sta nella compassione, in quell’amore gratuito e attivo che lo spinge a intervenire per alleviare le miserie del suo popolo.
In Gesù fremono le viscere materne di Dio, la sua divina misericordia. Prima ci siamo chiesti quale è il nostro modo di guardare, ora potremmo chiederci quale è il nostro modo di sentire. Cosa sentiamo, proviamo, nella relazione con le nostre comunità e con le singole persone. In altre parole, sarebbe interessante andare ad esaminare il nostro mondo emotivo per conoscere, distinguere o riconoscere, accogliere, purificare le emozioni, i sentimenti, gli affetti che vivono in noi e che possono facilitare o ostacolare il nostro ministero presbiterale.
Terza parte. La messe e la preghiera (9,37-38)
Si passa dall’immagine pastorale a quella agricola, dal gregge al campo di grano. È un’immagine antica riferita al compimento dei tempi. “Si affrettino e salgano le genti alla valle di Giòsafat, poiché lì siederò per giudicare tutte le genti all’intorno. Date mano alla falce, perché la messe è matura” (Gl 4,12-13a).
La messe è dunque Israele, campo pronto per la mietitura. L’abbondanza della messe sottolinea il compimento della speranza e l’urgenza dell’impegno per quelli che sono associati al compito di convocare gli uomini per il giudizio salvifico.
Le guide non assolvono il loro compito, non realizzano la missione loro affidata. Non si comportano da veri operai nel campo di Dio. Molti vestono l’abito del dottore della legge o del sacerdote del tempio ma hanno smarrito il vero senso, il vero spirito di questa vita, della loro vocazione, del loro compito connesso a questa autorità e alla responsabilità nei confronti della gente.
Dunque, l’affermazione che gli operai sono pochi si riferisce piuttosto alla mancata corrispondenza di queste guide. Pochi sono gli operai autentici, le vere guide del popolo, pastori secondo il cuore di Dio capaci di preparare all’incontro con il Messia.
Di fronte al gregge senza pastore, o alla messe abbondante, Gesù non procede con un “all’opera”, ma con un “pregate”. Questa preghiera ci aiuta a ricollocarci adeguatamente verso Dio (siamo suoi, è Lui che ci manda), e verso il gregge o la messe (è di Dio e non nostra: non possiamo correre il rischio di cadere in certi attaccamenti a contesti, persone o comunità). È Dio che manda i suoi pastori per il suo popolo (come ha mandato quei discepoli, 4,18-22, e ciascuno di noi).
Un elemento interessante da rilevare è il fatto che coloro i quali sono invitati a pregare perché il padrone della messe mandi operai, sono gli stessi che sono inviati da Gesù e con lui condividono la stessa missione (invitati e inviati). Possiamo dunque dire che la preghiera precede e accompagna la missione, ne è l’ambito vitale; si accoglie e si compie la missione come frutto-derivazione della preghiera. Preghiera e missione, e attività pastorale, e vita…
Da una parte siamo missionari nella misura in cui la nostra missione è preceduta e accompagnata dalla preghiera; dall’altra la preghiera al padrone della messe sarà autentica nella misura in cui ci si mantiene a disposizione per questo compito (fin dal seminario è uno dei criteri più importanti per il discernimento: la docibilitas: disponibilità a lasciarsi formare, a lasciarsi coinvolgere, a lasciarsi; a lasciarsi, lasciare se stessi…).
La preghiera è necessaria per l’autenticità della missione, e la disponibilità alla missione è necessaria per l’autenticità della preghiera.
A proposito dell’autenticità della preghiera per le vocazioni: “Cardine di tutta la pastorale vocazionale è la preghiera comandata dal Salvatore (Mt 9,38). Essa impegna non solo i singoli ma anche le intere comunità ecclesiali…” (NVNE 25e).
Dunque, la considerazione che la messe è molta e gli operai sono pochi, come anche l’esortazione a pregare il padrone della messe affinché mandi operai nella sua messe, non possono significare, in modo riduttivo, che Dio dovrebbe chiamare un numero maggiore di persone.
Ciò significherebbe fare un torto alla sua amorevole provvidenza nei confronti dei bisogni della Chiesa; come se Dio non chiamasse in modo sufficiente. Il testo, d’altro canto non dice pregate il padrone della messe perché mandi più operai nella sua messe.
La preghiera che Gesù invita a fare non è orientata ad un semplice incremento numerico delle vocazioni presbiterali; tanto meno a convincere Dio ad essere più generoso.
Ogni preghiera di domanda non è pronunciata per informare Dio, e neppure per indurlo a fare secondo le nostre richieste. Dice S. Agostino: “Potrebbe sembrare strano che Dio ci comandi di fargli delle richieste quando egli conosce, prima ancora che glielo domandiamo, quello che ci è necessario. Dobbiamo però riflettere che a lui non importa tanto la manifestazione del nostro desiderio, cosa che egli conosce molto bene, quanto piuttosto che questo desiderio si ravvivi in noi mediante la domanda, affinché possiamo ottenere quello che egli è già disposto a concederci” (Lett. 130 a Proba). “Dio non dà se non a chi chiede, per non dare a chi non riceve” (In Ps. 102, 10);
Che Dio chiami continuamente non è in discussione, e il come o il quanto non sta a noi determinarlo: soltanto lui conosce le vere necessità della Chiesa come pure i cuori di tutti gli uomini.
Dunque, l’accento della preghiera non cade tanto sul numero dei chiamati, quanto sulla loro vera realizzazione. Questa preghiera mira a domandare a Dio che ciascun chiamato, quanti egli vuole e come egli sa, corrisponda alla sua iniziativa e sia un vero operaio per la messe di Dio. A questo proposito S. Gregorio Magno così si esprime: “Per una grande messe gli operai sono pochi. In questa scarsità non possiamo parlare senza profonda tristezza, poiché vi sono persone che ascolterebbero la buona parola, ma mancano i predicatori. Ecco, il mondo è pieno di sacerdoti, e tuttavia si trova assai di rado chi lavora nella messe del Signore. Ci siamo assunti l’ufficio sacerdotale, ma non compiamo le opere che l’ufficio comporta” (Omelie sui vangeli, Omelia 17, 3, PL 76, 1139).
In conclusione
Gesù ha davanti a sé delle folle che appaiono stanche e sfinite come pecore senza pastore ma il suo sguardo è capace di vedere una messe abbondante, biondeggiante, pronta per la mietitura.
È questo un richiamo al tema della speranza. La speranza che permette al nostro cuore di riconoscere in ogni essere umano la presenza di una messe pronta per la mietitura.
«…la speranza è il segreto della vita cristiana. Essa è il respiro assolutamente necessario sul fronte della missione della Chiesa e in particolare della pastorale vocazionale (…). Occorre quindi rigenerarla nei presbiteri, negli educatori, nelle famiglie cristiane, nelle famiglie religiose, negli Istituti Secolari. Insomma, in tutti coloro che devono servire la vita accanto alle nuove generazioni» (NVNE 3).
L’ingaggio dei mietitori, come il tempo della mietitura, sta sotto la sovrana e libera iniziativa di Dio, il Signore della messe. Il primo compito di noi discepoli è quello di pregare perché siano inviati gli operai… e pregare significa già sintonizzarci e renderci disponibili al progetto salvifico rivelato e inaugurato da Gesù con la sua missione.
In questa direzione mi sembrano significative le parole pronunciate da Papa Leone nella sua prima udienza generale il 21 maggio scorso: «Noi siamo abituati a calcolare le cose – e a volte è necessario –, ma questo non vale nell’amore! Il modo in cui questo seminatore “sprecone” getta il seme è un’immagine del modo in cui Dio ci ama. È vero, infatti, che il destino del seme dipende anche dal modo in cui il terreno lo accoglie e dalla situazione in cui si trova, ma anzitutto in questa parabola Gesù ci dice che Dio getta il seme della sua parola su ogni tipo di terreno, cioè in qualunque nostra situazione: a volte siamo più superficiali e distratti, a volte ci lasciamo prendere dall’entusiasmo, a volte siamo oppressi dalle preoccupazioni della vita, ma ci sono anche i momenti in cui siamo disponibili e accoglienti. Dio è fiducioso e spera che prima o poi il seme fiorisca. Egli ci ama così: non aspetta che diventiamo il terreno migliore, ci dona sempre generosamente la sua parola. Forse proprio vedendo che Lui si fida di noi, nascerà in noi il desiderio di essere un terreno migliore. Questa è la speranza, fondata sulla roccia della generosità e della misericordia di Dio».